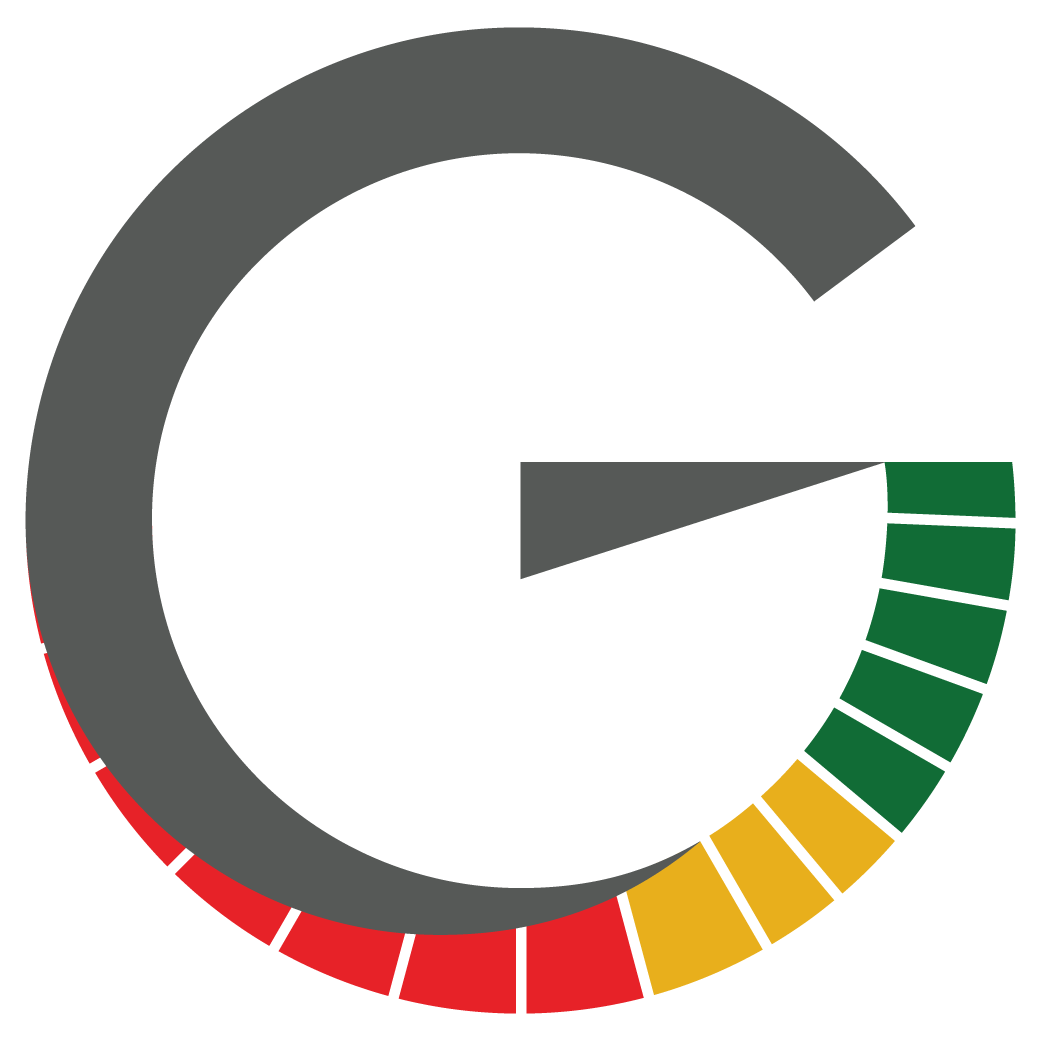Chi lavora nell’ambito della Grande Distribuzione Organizzata e ha familiarità con i retail store nel settore della moda avrà ben presente l’importanza nell’efficienza della gestione dei resi. Permettere ai clienti questo servizio può infatti dare una spinta non indifferente alle vendite, ma è fondamentale saperlo gestire al meglio per evitare che si trasformi in una pericolosa arma a doppio taglio. Tuttavia, vi sono anche tipologie di resi cosiddetti “fraudolenti”.
Ciò avviene quando il cliente acquista un oggetto – magari una fotocamera – per utilizzarla una sola volta e poi restituirla, chiedendo un rimborso. Nel campo dell’abbigliamento, questa pessima abitudine viene definita wardrobing ed è un fenomeno in costante crescita: si acquista un vestito costoso e lo si indossa in una sola occasione specifica, per poi restituirlo in negozio. Ma è possibile contrastare questa dannosa pratica?
Potrebbe interessarti anche:
come ottimizzare la gestione dei resi nella Grande Distribuzione Organizzata
Quanto è diffuso il wardrobing e chi lo pratica
Va innanzitutto specificato un dettaglio non da poco: data la politica dei resi praticata dalla maggior parte dei negozi, il wardrobing non si può al momento considerare una pratica illegale. Si tratta di un’abitudine scorretta e deprecabile da un punto di vista etico, ma non infrange la legge; proprio per questo si stima che oltre il 10% dei clienti di un negozio di abbigliamento acquisti un capo con l’intenzione di provarlo una sola volta e di effettuarne poi il reso. Una pratica comune soprattutto tra i giovani compresi fra i 25 e i 35 anni di età.
Il wardrobing è ormai ben conosciuto anche dagli stessi retailer: si stima che due negozianti su tre conoscano personalmente i clienti che attuano questa pratica; alcuni di essi possono rendere addirittura una ventina di capi all’anno. In alcuni casi si formano delle vere e proprie reti di wardrober che si organizzano, tramite lo scambio di informazioni, per individuare i negozi nei quali è meno probabile vedersi rifiutato un reso. Una brutta gatta da pelare per i retailer, che si unisce alla spietata concorrenza dei colossi dell’e-commerce.
Ma chi sono le persone che maggiormente contribuiscono alla diffusione di questa pessima abitudine? Per la maggior parte si tratta di motivi davvero futili, come ad esempio la gloria sui social network. Il 10% dei wardrober dichiara di farlo solo per potersi fotografare con il capo indosso e condividere lo scatto su Facebook o Instagram; ciò ha potato alcuni dei maggiori retailer a spendere una porzione delle loro risorse a controllare questi canali. Un’operazione di contrasto che solo le grandi catene, purtroppo, possono permettersi.
Quale impatto ha il wardrobing in un’attività retail
Migliorare la gestione del proprio inventario e investire sui software per il controllo e la disponibilità della merce, dunque, diventa quasi inutile nel momento in cui questo fenomeno continua a crescere inesorabilmente. Vendere tanto e vendere bene, dopotutto, ha poco senso nel momento in cui una discreta fetta della merce viene restituita e rimborsata; se poi l’articolo soggetto del reso è anche l’ultimo a disposizione in magazzino, allora la faccenda si complica ulteriormente perchè ne viene impedito l’acquisto anche ai clienti onesti.
Questo avviene perchè un prodotto, quando viene venduto ed è in seguito soggetto a un reso, non torna immediatamente sugli scaffali ma viene rispedito nei centri di lavorazione e nei magazzini; qui vengono ricondizionati e preparati per tornare finalmente a disposizione dei clienti. Purtroppo questo lasso di tempo si rivela spesso eccessivamente lungo: l’articolo rischia di andare fuori stagione e di finire così invenduto (oppure messo in saldo), causando così più di qualche problema alle casse dell’attività.
Contrastare il wardrobing: le possibili soluzioni
Cercare di contrastare un fenomeno così ambiguo si sta rivelando impresa davvero ardua anche per le aziende più grandi e strutturate. Alcune di esse hanno provato a giocarsi la carta dell’ironia, provando a trasformare – grazie a delle campagne pubblicitarie realizzate ad hoc – questo problema in un’arma promozionale a proprio favore: il brand in questione, per la cronaca, è Diesel, un vero colosso: questo lascia chiaramente intendere che questa strada sia percorribile solo da chi possiede già delle solide fondamenta.
Solo le grandi multinazionali dell’abbigliamento possono dunque salvarsi? No, assolutamente: alcune piccole imprese hanno già messo in atto altre strategie che potrebbero, nel tempo, rivelarsi salvifiche: l’uso di specifiche e ingombranti etichette, ad esempio, che vanno tagliate in seguito all’acquisto – seguendo precise istruzioni – e che potrebbero rendere immediatamente riconoscibile al commesso di turno un capo già utilizzato. Questa soluzione è attualmente in fase sperimentale negli Stati Uniti.
Un altro metodo ben più drastico per contrastare il wardrobing consiste nello stilare delle blacklist – delle liste nere – di consumatori che abusano del servizio di reso, raccogliendo i loro dati ed estromettendoli da ulteriori futuri tentativi di restituzione. È necessario infine inasprire le restituzioni che vengono effettuate senza scontrini o prove d’acquisto. Il wardrobing è un territorio tutt’ora nuovo ed inesplorato che costa ai retailer milioni di euro ogni anno: trovare una soluzione a tali pratiche diventa così fondamentale per garantire la sopravvivenza del settore.